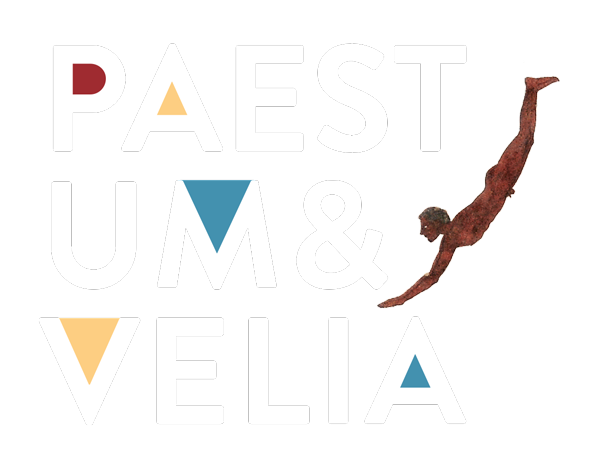Il 19 settembre scorso, il direttore Gabriel Zuchtriegel ha ricevuto questa lettera da parte di Pino Anzani.
Ne riportiamo il contenuto nella convinzione che il confronto, anche con chi ha pensieri diversi dai propri, sia sempre costruttivo.
Voi cosa ne pensate dell’opera di Mimmo Paladino?
Fatecelo sapere, attendiamo anche le vostre lettere.
Premetto che sono un estimatore del nuovo corso dei grandi musei ed aree archeologiche italiani, e in particolare dell’operato di Gabriel Zuchtriegel a Paestum, fortunatamente confermato nel suo ruolo. La critica che muovo è pertanto indirizzata a una singola iniziativa pestana, cioè l’installazione del cavallo di Mimmo Paladino tra il Tempio di Nettuno e la Basilica, per usare i nomi con cui sono maggiormente noti.
Ho potuto osservare l’installazione di notte, quando emerge fra i due templi dal buio fitto che avvolge gli scavi, e la suggestione è stata notevole, con la sagoma verticale del cavallo a segnare il vuoto tra i grandi volumi geometrici scanditi dal ritmo vibrante dei colonnati dorici. Ma questa suggestione credo nasconda un corto circuito culturalmente pericoloso, che resta in agguato ogni qualvolta i contesti storici e archeologici sono chiamati a confrontarsi con manufatti che si ispirano all’antichità in modo più o meno esplicito, quando non schiettamente modellati su forme classiche (come le opere di Mitoraj a Pompei).
Il rischio, in altri termini, è che l’installazione contemporanea, invece di rappresentare una discontinuità nella trama dei rapporti visivi stratificati nei secoli, e creare così un confronto stimolante e virtuoso tra epoche differenti, vi vada invece a calzare più meno a pennello, aggiungendo una variazione immediatamente digerita e fatta propria dal sito, col risultato — a seconda della sensibilità e della cultura dei fruitori — di esser percepita come una componente omogenea dell’insieme, pacificamente adottata da questo (diventando quindi un falso), o di trasformare il sito in una scenografia, in questo caso di un film “peplum” (riverberando quindi la sua “finzione” sul contesto). In effetti alcuni scorci degli scavi di Pompei con le installazioni di Mitoraj non avrebbero sfigurato nel “Satyricon” felliniano e, tornando alle suggestioni cinematografiche del “peplum”, chi come me ha fatto in tempo a vedere questi film avrà forse colto — dopo l’innegabile suggestione del primo sguardo — un’eco dei Cavalli di Troia cinematografici nell’elegante stilizzazione dell’opera di Paladino.
In altri termini, quanto maggiore è la prossimità del linguaggio formale dell’oggetto contemporaneo al contesto culturale antico, tanto più alto è il rischio di una percezione falsificata, consapevole o — peggio — inconsapevole, da parte dei visitatori.
È appena il caso di aggiungere che, naturalmente, queste considerazioni non attengono ai valori artistici delle opere citate, e che semmai il valore di tali opere potrebbe entrarci per il versante economico, volendo ampliare il discorso al campo del marketing — cosa che appunto qui non si vuol fare, ritenendo abbastanza forte e propedeutica alle altre l’istanza culturale. Né credo che il ricorso a opere schiettamente contemporanee sia priva di controindicazioni, dato che anche in tale circostanza tutto va ovviamente affidato al discernimento dei responsabili.
In esso continuiamo a confidare, senza trascurare però i rischi sin qui esposti sulla base di considerazioni che hanno, se non altro, il pregio della prudenza e della coerenza con alcuni dei criteri più attendibili in materia di intervento nei contesti storici.
Pino Anzani
Architetto, coautore del dossier Paestum-Cilento/Unesco