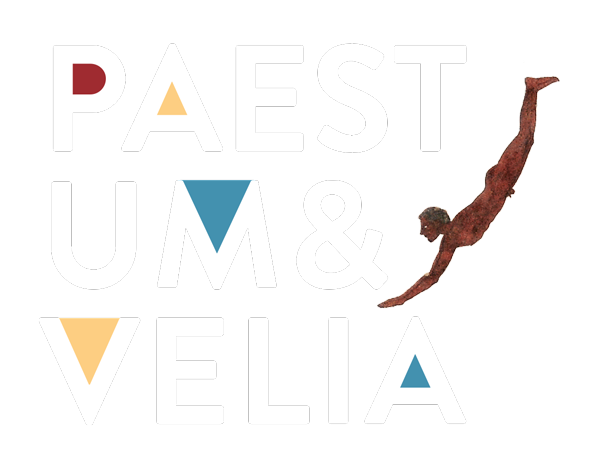La fondazione della città
Paestum fu fondata come “Poseidonia” da coloni greci, arrivati qui con le loro navi dalla città di Sibari in Calabria intorno al 600 a.C.
Prima la zona era abitata da gruppi indigeni. I rapporti tra loro e i greci sono ancora poco chiari, speriamo di avere più informazioni dai nuovi scavi che si faranno a Paestum e nel territorio circostante.
Nella seconda metà del VII sec. a.C., i Greci si stabilirono in una fortezza su una roccia sul mare, nell’attuale Agropoli, a Sud di Paestum. Lì costruirono un tempio per Poseidone.
Intorno al 600 a.C. si spostarono nella pianura e fondarono Poseidonia-Paestum, sulla riva sinistra del fiume Sele. Sin dal loro arrivo, i coloni si preoccuparono di dividere gli spazi: i quartieri abitativi furono nettamente distinti da un’ampia fascia centrale destinata a funzioni pubbliche. Quest’ultima, a sua volta, venne suddivisa in tre aree: quelle a nord e a sud, dedicate alle divinità, in cui ancora oggi possiamo ammirare i tre maestosi templi dorici; quella centrale, riservata alle attività politiche e commerciali (agorà).
L’agorà, ossia la piazza principale della città greca, era il suo cuore pulsante. Il lato sud di questo spazio aperto, in età romana, fu prescelto per ospitare il Foro.
Sull’agorà furono realizzati due monumenti simbolici dell’immagine politica della città. Il primo, definito “heroon”, è una struttura a camera parzialmente scavata nella roccia intorno al 520 a. C. e costruita in onore del mitico eroe fondatore della colonia. L’edificio fu rispettato dai Lucani, mentre i Romani, al loro arrivo, realizzarono un recinto rettangolare, oggi visibile, e lo ricoprirono di terra ponendo fine al culto. Al suo interno è stato ritrovato un corredo eccezionale, conservato all’interno del Museo Archeologico.
Il secondo edificio, l’ekklesiasterion, di forma circolare, fu realizzato intorno al 480 a. C. per ospitare i cittadini maschi che si riunivano per discutere di questioni politiche.


Cittadini ed artigiani
Inizialmente ogni cittadino aveva una casa in città e un pezzo di terra in campagna. Delle abitazioni di età greca si conosce molto poco: infatti, sono stati scoperti soltanto alcuni ambienti di una casa di V secolo a.C.
I diritti e i doveri del cittadino comprendevano l’attività politica, il servizio militare e la partecipazione alla vita religiosa della comunità. Solo il cittadino adulto maschio poteva partecipare alle assemblee e, da ogni forma di partecipazione politica, erano esclusi le donne e gli schiavi. Le tappe della vita maschile e femminile erano segnate da numerosi riti di passaggio, in cui, sotto la protezione di una divinità, si celebrava il nuovo ruolo assunto dall’individuo nella società greca (adolescente/maschio adulto; fanciulla/donna sposata).
Quando la comunità si allarga e diventa più diversificata, anche la condizione dell’artigiano migliora gradualmente.
Nel VI a. C. e nel V a. C. le botteghe dei ceramisti di Poseidonia realizzano vasi di uso comune e da mensa, mentre alla fine del V a. C. cominciano ad essere fabbricati vasi figurati dipinti (a figure rosse). Tra i più conosciuti ceramografi pestani spicca Assteas, attivo tra il 380 e 350 a. C., che firmò i suoi prodotti con il proprio nome. L’unico suo vaso conservato a Paestum, dipinto con il mito di Bellerofonte e utilizzato per attingere e contenere acqua (hydrìa), proviene da una tomba a camera di Agropoli.

La città dei morti
I greci seppellivano i morti fuori le mura, nelle “necropoli” (“città dei morti”). Le tombe e i corredi funerari rispecchiano lo status sociale della famiglia del defunto, nonché le aspettative e i valori della comunità.
I corredi provenienti dalle necropoli urbane più antiche, dei primi coloni venuti da Sibari (città della Calabria), presentano, molto spesso, nelle sepolture maschili, uno strumento utilizzato per la detersione del corpo (“strigile”) ed un vaso per contenere profumi (“alabastron”): oggetti che sembrano mettere in evidenza gli ideali atletici dei Greci.
Nelle sepolture successive, quando Poseidonia era dominata da genti provenienti dall’entroterra montuoso (i Lucani), emerge un ruolo fortemente militare del defunto maschio che viene deposto con armi di offesa e, spesso, con la sua armatura (elmo, corazza, schinieri). Caratteristiche delle sepolture appartenenti ai guerrieri armati è il motivo del c.d. “ritorno del guerriero”, associato alle rappresentazioni di corsa di bighe, pugilato e duello che rimandano ai giochi funebri svolti in onore del defunto.

L’entroterra
Inizialmente i coloni si insediarono nella pianura fertile lungo la costa; sulle montagne dell’entroterra vivevano altre popolazioni con i quali i Greci avevano rapporti variegati: a fasi di pace seguivano fasi di conflitti violenti.
Fin dal loro arrivo, i coloni greci affermano di essere i “signori” di un vasto territorio e ne marcano i confini con la costruzione di santuari che pongono i nuovi possedimenti sotto la protezione delle divinità: a nord, il santuario di Era presso il fiume Sele separa il versante abitato dai Greci dalla terra degli Etruschi. A sud, sul promontorio di Agropoli, sorge il santuario di Poseidone. Sulle colline alle spalle della città sceglie di abitare la dea del paesaggio selvatico, Artemide.
A una distanza ancora maggiore, piccoli santuari di campagna, sorti vicino alle sorgenti o alle strade, hanno la funzione di unire le popolazioni contadine nel segno di un culto rivolto, oltre a Era, soprattutto a Demetra, la divinità che concede agli uomini il dono della spiga di grano (alla dea si riferisce un altro importante luogo di culto a carattere extraurbano, situato in località S. Nicola di Albanella).
I Greci non amavano molto vivere “in periferia”, e quindi scelsero la fertile pianura di Poseidonia come spazio da destinare alla coltivazione dei cereali; infatti, questo tipo attività avrebbe permesso ai cittadini di occuparsi delle questioni importanti di cui si discuteva in città senza passare troppo tempo in campagna. Un significativo cambiamento si registra due secoli dopo l’arrivo dei primi coloni, quando, in seguito al cambiamento della società, tutta la campagna pestana viene scelta per essere abitata occupata in maniera stabile da gruppi di cui sono state indagate le necropoli.