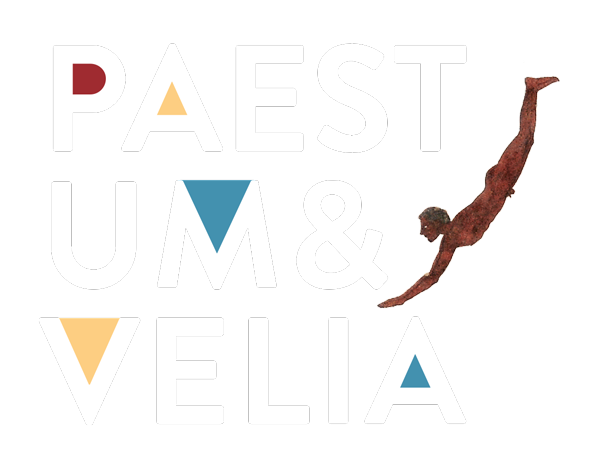ecco il testo integrale della conferenza di Paul Carter

Lancio di Metabolism, Museo di Paestum, 28 June 2018
Innanzitutto, vorrei ringraziare Gabriel per l’invito a presentare questo breve studio de il tuffatore nel contesto del cinquantesimo anniversario della scoperta de La tomba del tuffatore.
Vorrei anche ringraziare il suo staff per aver organizzato gli aspetti pratici di questa visita.
In Australia parliamo di ‘luoghi sacri’. Questi sono luoghi di pellegrinaggi ancestrali dove si sa che risiedono gli dei. Dove ci sono grotte, ci possono essere pitture rupestri, stranamente collocate nell’oscurità. Ci si avvicina ad esse con molta cura; generalmente viene fatta un’offerta. Metabolism è un’offerta in questo spirito.
Innanzitutto, dovrei spiegare il titolo. E’ ispirato da un brano trovato nel trattato di Kierkegaard Il concetto dell’angoscia. Discutendo l’approccio di Platone alle obiezioni eleatiche alla dotrina del’uno e dei molti, Kierkegaard scrive:
‘Il metodo come sempre è quello della dialettica sperimentale. Si assume che l’unità è e non è, e quindi si mostra quale sarebbe la conseguenza per essa e per il resto.
L’istante sembra essere ora quello strano essere (atopon – la parola greca viena ammirevolmente scelta) che giace/si trova tra il movimento e il riposo, senza occupare alcun tempo; e verso di esso e fuori da esso ‘il muoversi’ passa oltre nel resto, e ‘il riposare’ nel movimento. L’istante quindi diventa la generale categoria di transizione (metabole); poiché? Platone mostra che l’istante è collegato/associato nello stesso modo alla transizione dall’unità alla pluralità e dalla pluralità all’unità, dalla somiglianza alla non somiglianza, ecc, è l’istante in cui non c’è né en né polla, né discriminazione né integrazione.
Il tuffatore illustra/chiarisce/spiega la natura dell’istante platonico con rigore quasi etimologico; meta + ballein = gettarsi oltre – ricevendo questo come un’istruzione, il tuffatore si getta dalla colonna per i tuffi/d’immersione. Si getta oltre la rettitudine, facendo di nuovo di se stesso la figura del cambiamento.
Quindi qui ci viene indicata non soltanto l’intenzione del dipinto, ma il paradosso del dipinto, l’impossibilità di catturare il movimento in una immagine che non si muove. O, in modo più sottile, catturare il cambiamento in un’immagine che è, o è stata, immortale per due millenni e mezzo.
E pertanto, per arrivare al tema del mio saggio, se noi diciamo che l’immagine si rivolge/fa appello all’occhio interiore dell’immaginazione – e non soltanto all’occhio esteriore della percezione – come viene l’invisibile, ciò che è stato seppellito lontano dalla vista, mantenuto nell’immaginazione? Dobbiamo immaginare la sua apparenza (come se non fosse stata mai persa)? O, nell’accedere all’interno delle mura della tomba oggi, dobbiamo includere, cioe riconoscere, l’oscurità, e vedere qualsiasi cosa noi vediamo attraverso la memoria dell’oscurità?
Nel mio saggio parlo delle sfide che queste questioni presentano all’esposizione de il tuffatore (e per estenzione di tutte quelle opera d’arte fatte per l’oscurità). Come può l’invisibilità essere vista? Gabriel mi ha detto che un visitatore gli ha chiesto perché la tomba del tuffatore non fosse esposta come “è stata originariamente ritrovata”! Forse questo visitatore non ha considerato la logistica! Ma c’è un punto che va più in profondità: per essere trovata, la tomba ha dovuto essere aperta. Scoperta e illuminazione vanno di pari passo.
Per quanto riguarda il museo, (dobbiamo ricordarci che) è dedicato all’”illuminismo,” cioe a un’illuminazione percettivo anche intellettuale. Non è responsabilità dell’educazione pubblica far svanire le ombre, anche se ciò implica una mancanza di rispetto nei confronti dei desideri dei morti?
Pertanto/Di conseguenza uno degli scopi del mio saggio è di attirare l’attenzione sulle supposizioni che noi facciamo riguardo al vedere, all’osservare – come se l’osservare fosse un’attività innocente mentre, in realtà, come nella conservazione e nell’esposizione de il tuffatore, è un atto consapevole di costruzione di un punto di vista.
Inoltre, il punto di vista costruito esprimerà un’idea su un’osservazione buona o la rivelazione ideale: livelli fissi di luce, la progettazione di un punto di vista ideale e, nei nostri tempi, l’importanza di una iper-visione (animazioni digitali che possano aiutarci ad immaginare la posizione originale).
In L’immagine invisibile, il gruppo curatoriale ha esplorato questo tema dal punto di vista storico: in diversi periodi storici noi abbiamo immaginato l’invisibile in modo diverso, e abbiamo perciò assegnato significati diversi, religiosi, politici, filosofici alle immagini e alle storie che vengono dall’aldilà (l’Oltretomba). L’invito è ad osservare/guardare in uno specchio storico e a riflettere sul modo in cui vediamo; perché, naturalmente, ciò che noi vediamo là è inevitabilmente un riflesso dei nostri interessi.
Naturalmente, come ho indicato, queste questioni sono state stimolate in me da il tuffatore: non dalla progettazione degli interni delle tombe di Paestum in generale, ma da questa immagine particolare del metabole che mi ha spinto a chiedermi come l’invisibile viene rappresentato, poiché l’immagine stessa sembrava incarnare il paradosso. L’immagine dell’istante è un tuffatore (o un tuffo, o entrambi); e mentre io ero interessato alla sfida di immergere questa figura nella luce – a far scaturire domande per la museologia e la memoria – come chiunque altro, io ero anche affascinato dalla scelta del soggetto.
Naturalmente, esistono studi accademici ampi ed approfonditi, testuali, iconografici, stilistici ed archeologici, che servono a demistificare l’immagine, che mirano, come ogni ”illuminismo”/”illuminazione”, a rendere l’immagine meno originale, meno misteriosa, ma io mi sono avvicinato all’identità del tuffatore in modo diverso: attraverso la storia culturale del tuffarsi (il tuffo) – la parola italiana ha, forse in modo indicativo, un significato molto più ampio che in inglese: mentre to dive fa riferimento ad una precisa inversione/cambio di direzione, tuffare/tuffarsi abbraccia/include ogni tipo di immersione, esperta o inesperta.
Ma quando ho cercato informazioni sul tuffo classico/sul tuffarsi nella classicità con sorpresa ho scoperto che il tuffarsi nel senso misurato dipinto ne il tuffatore non è descritto in nessuna parte di ciò che rimane della letteratura greca e romana. (E, come noi sappiamo, con una parziale eccezione per gli Etruschi,non è da nessuna parte dipinto in arte). Naturalmente, ci sono molti salti, immersioni di testa e spedizioni subacquee. Si conoscono anche tuffi dalla cima di scogliere/dirupi: ma artisti del tuffo come il tuffatore non si conoscono.
Quando scrive dell’ode nella quale il contemporaneo di Pindaro, Bacchilide, descrive l’immersione di Teseo nel fondo del mare, Burnett afferma che “I Greci non erano un popolo di nuotatori, per loro un tuffo era un atto sia favoloso sia significativo”.
Ora il buon senso protesta, e ritiene che ciò non può essere stato vero; tuttavia, fatta eccezione per i racconti sulle immersioni per la pesca delle spugne di Delo (che, dopo tutto, non si tuffava), si dice che l’antico Mediterraneo fosse privo di tuffatori. E’ come se la familiarità collettiva con una attività quotidiana (il tuffarsi) sia stata seppellita, come un tesoro naufragato, lontano dalla vista della memoria storica! (Ed attenda la scoperta ed il recupero).
Ma qui c’è qualcosa di ancora più strano: possiamo continuare la nostra ricerca in avanti, verso l’alto attraverso i secoli che si succedono – verso l’alto, in avanti infatti, fino all’inizio del ventesimo secolo quando viene inventato lo sport del tuffo dal trampolino (high-diving: è giusto?) – con risultati ugualmente negativi. Non soltanto non ci sono tuffatori nell’arte occidentale: sono assenti dalla poesia e dalla prosa; sono persino assenti come figure retoriche filosofiche o psicologiche.
Naturalmente, come ho detto, ci sono molte figure che si immergono da Lucifero in giù. Ma di quella ambigua classe di persone a loro agio nello spazio tra la terra e il mare, nel navigare le possibilità/le occasioni e non assalite dalla paura di cadere: di questa razza integrata a livello psicologico e ambientale non sappiamo quasi nulla.
Alla presenza del vostro giovane direttore non sono pronto a dire quando io per la prima volta ho visto il tuffatore. Diciamo semplicemente che il dipinto in quei tempi era ancora giovane. In seguito ho trasferito la mia residenza dall’Italia all’Australia, immergendomi, come è stato, (nell’aldilà eliminare?), nell’Underworld, nel mondo ‘sotto’.
Ma sempre ho ricordato il mondo ‘sopra’, the Upper world, e la sua immagine di qualcuno che era riuscito a passare tra i due mondi con tanta grazia. Mentre navigavo attraverso l’ambiente turbolento della migrazione, ripetutamente ritornavo al tuffatore come guida: il suo dono di riuscire a gestire circostanze pericolose era qualcosa che volevo imparare.
Nel corso di quel viaggio, ho imparato qualcos’altro. Non soltanto il tuffatore era ormai intrecciato alla mia vita: era intrecciato alla vita di tutti I tempi Inoltre, nello specchio dei nostri interessi, le ricostruzioni legittime degli archeologi e degli storici potrebbero essere ampliate. Per esempio, l’ipotesi di Mario Napoli che il tuffatore rappresenti una concezione pitagorea della migrazione dell’anima: non mette in evidenza Giamblico la prominenza dei seguaci pitagorei a Paestum? Ma ciò che noi sappiamo su questo Pitagora – ciò che raramente viene enfatizzato, è che egli era un rifugiato da Samos che morì, rifugiato, nel Mataponto. Più in generale, sappiamo che i Pitagorei che hanno goduto del potere politico nelle città della Magna Grecia all’inizio del Quinto secolo furono cacciati da quelle città. Sappiamo anche che in alcuni casi avvenne una sorta di apoleia inversa – alcuni di questi esuli, attraverso una migrazione inversa diventano rifugiati nella stessa Grecia!
Qui, le preoccupazioni dei nostri tempi gettano luce sulla circostanza politica e culturale che il tuffatore può aver prodotto. Pitagora, il filosofo sciamano dell’esilio e, sicuramente, il sostenitore ideale dei diritti dei rifugiati. E in certo senso come può essere questa interpretazione più speculativa dell’esposizione del dipinto stesso? Per vedere da dove proviene, dobbiamo vedere da dove proveniamo noi stessi; ed in quella dialettica una nuova etica della cura umana è, a mio parere, possibile e necessaria.
Gabriel è stato molto gentile ad invitarmi a sviluppare queste idee nell’imminente conferenza qui a Paestum; pertanto non dirò nulla di più in questa sede. Comunque, è nostra intenzione esplorare queste risonanze de il tuffatore con i nostri tempi in una serie di simposi il prossimo anno. Questi eventi, chiamati ‘Il futuro della memoria’, esplorano come ciò che viene ricordato è inseparabile dal modo in cui ricordiamo: entrambi sempre guardano al futuro e delineano un’etica della cura.
In chiusura, vorrei anche rendere omaggio al mio caro amico, Corbett Lyon, architetto, anche lui curatore, che con sua moglie Yueji, dirige il suo museo a Melbourne. Vorrei ringraziare anche il designer, Yanni Florence, e il direttore precedente del Museo di Paestum per il permesso di riprodurre le fotografie incluse nel libro. Lyon Housemuseum ha pubblicato Metabolism, un atto di grande generosità culturale che ci ricorda che la migrazione dell’immaginazione è senza confine quando i suoi doni vengono ricevuti e restituiti con interesse.
Vi ringrazio